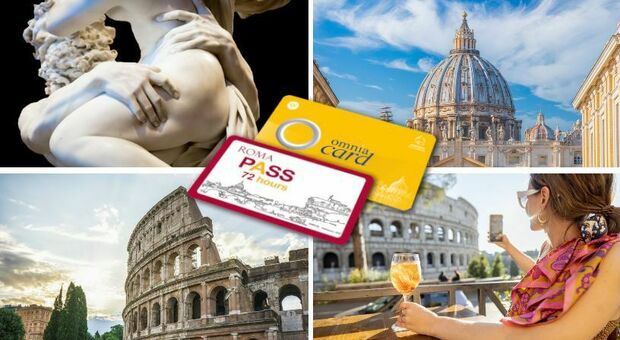L'amicizia tradita porta talvolta ad atti clamorosi. Nella vicenda di cui ci occupiamo chi ne fece le spese fu un bel busto di terracotta realizzato niente di meno che da Antonio Canova. Val dunque la pena nella ricorrenza dell'anno canoviano ricordare questa storia di rottura amicale che trascinò nel fango, e, come si vedrà, le parole sono adeguate, l'opera di un grande artista.
Ma andiamo con ordine.
Era uno scontro di grande rilievo perché si voleva restaurare, se non l'antica eguaglianza, almeno una maggiore coesione tra le diverse classi di nobili, assai divergenti per ricchezza, status sociale e possibilità di accedere a nomine rilevanti. Il numero di barnabotti, gli aristocratici poveri, così chiamati perché per lo più residenti attorno a San Barnaba, era cresciuto a dismisura e premeva sul governo. Angelo Querini dalla sua posizione di Avogadore intentò una serie di prove di forza nei confronti degli Inquisitori di Stato, cercando di riprendere le prerogative di azione e decisionalità della sua magistratura. La reazione non si fece attendere ma fu inaspettata nella sua durezza: Angelo Querini veniva arrestato mentre si trovava nel suo casino a San Moisé nella notte del 12 agosto del 1761 con l'accusa di aver tentato un complotto e immediatamente relegato nel castello di San Felice a Verona. La penna disincantata e satirica del poeta Giorgio Baffo chiosava questo provvedimento che giungeva come un fulmine a ciel sereno su un uomo apprezzato da tutti: «Quel grand'omo, quel spirito elevato, quel genio cussì puro, e cussì belo el xe messo, e serrà drento un castelo, né gnessun pol saver più del so stato».
L'amico Paolo Renier si batté fieramente, insieme ad altri, per la sua liberazione, rappresentando il capo del partito dei querinisti ma solo dopo due anni di dura prigionia e isolamento, nel settembre 1763, Querini poté essere liberato, sancendo di fatto la vittoria del partito avverso che sosteneva gli Inquisitori e il Consiglio dei Dieci. Uscito dal carcere Angelo Querini si applicò meno alla politica e si dedicò ai suoi studi, alla promozione di opere letterarie, frequentando Gasparo Gozzi, Melchiorre Cesarotti, Giuseppe Toaldo, Clemente Sibiliato, e corrispondendo con molti altri intellettuali, e cominciò a progettare la sua villa di Altichiero sulle rive del Brenta, sul terreno ereditato dal fratello Vincenzo. L'amicizia tra i due proseguì, anche se le strade iniziarono a differenziarsi. Paolo Renier si occupò prevalentemente della sua vita politica, eletto prima come ambasciatore alla corte viennese nel 1764, poi bailo a Costantinopoli nel 1769, dove conobbe la seconda moglie, Giovanna Margherita Dalmet, vedova e assai più giovane di lui. Tornato stabilmente a Venezia nel 1777 sembrò che la sua carriera stesse procedendo speditamente verso il soglio ducale come infatti avvenne nel gennaio del 1779 e Angelo Querini decise di commissionare il busto dell'amico in veste dogale al giovane scultore e assai promettente Antonio Canova, che infatti lo riferisce nel suo taccuino. Si tratta di una delle sue rare produzioni nel periodo veneziano e ben presto Canova, già nell'autunno del 1779, si sarebbe spostato a Roma. Querini aveva ideato il busto per il suo studiolo, come se volesse l'amico sempre accanto a sé. Ma se in Querini il radicamento nelle idee illuministe si fece più profondo e lo spinse a un viaggio insieme all'abate Alberto Fortis e al medico Girolamo Festari in Svizzera per conoscere, con altri filosofi e scienziati, Voltaire e omaggiarlo di una medaglia, Paolo Renier maturava posizioni ben più moderate.
La distanza di pensieri e orientamenti tra i due si andava facendo più cospicua, tuttavia la rottura dell'amicizia avvenne qualche anno dopo, attorno al 1787; forse dipese dalla mancata elezione del Querini nella carica di Primicerio di San Marco, nonostante la promessa fattagli dal doge, ma non dovette neppure essere estranea la posizione del Renier rispetto al piano di regolazione delle acque del Brenta. Fu proprio un sodale del Renier che lo propose, ma quegli interventi avrebbero creato problemi all'amata tenuta di Altichiero. A lungo Querini ebbe a scontrarsi con tale progetto, rispondendo con opuscoli, rilievi, infine con un'accurata dissertazione a titolo Considerazioni ed allegati per la più pronta sicura ed economica regolazione di Brenta secondo il piano esibito ai pubblici consigli ed al giudizio della nazione che sarebbe stata pubblicata nel 1789. Se prima il busto del Canova gli aveva fatto buona compagnia tra libri e oggetti preziosi, presto gli divenne odioso. Fu così trasportato nel giardino di Altichiero che il Querini aveva progettato come spazio filosofico, in sintonia con l'estetica illuministica, e che venne descritto a stampa dalla cara amica Giustiniana Wynne Rosenberg che vi soggiornò a lungo. Ma non trovò posto tra le statue che lo corredavano, tra filari d'alberi, pergolati, salottini ameni e il caffé house, un piccolo padiglione in onore del dio dei giardini, e neppure presso l'altare dell'Amicizia. Venne invece gettato dietro l'altare delle Furie, che rappresentavano Ignoranza, Invidia e Calunnia, nell'angolo estremo del vasto giardino: un posto recondito che secondo alcuni testimoni del tempo era usato per «soddisfare i bisogni corporali di chiunque». Il busto rimase in quella posizione degradante fino alla morte del Querini avvenuta per malore all'uscita del teatro di San Moisé il 30 dicembre del 1796.
Ne fu probabilmente ignaro il Renier che morì molti anni prima, il 14 febbraio 1789. Fu il nipote Lauro Querini, esecutore testamentario, a pulire e spostare il busto all'interno della villa, poi suo figlio Costantino, il pronipote di Angelo, lo vendette all'antiquario padovano Luigi Rizzoli dal quale venne acquistato nel 1864 da Nicola Bottacin, ricco e colto commerciante, vicentino di origine e triestino d'adozione. Costui lo pagò a caro prezzo, dopo essersi assicurato che fosse di mano del Canova, pur trovandolo con il capo separato dal collo e il corno dogale spezzato. La villa intanto era già passata di proprietà della famiglia Soster ma con la prima guerra mondiale divenne stanza militare e il giardino fu devastato. La dimora filosofica di Angelo Querini venne infine demolita e rimase solo l'oratorio. Tuttavia questa vicenda di amicizia tradita custodita dal busto del Canova ha ripreso a narrare la sua storia e a testimoniare l'estro giovanile del grande scultore grazie al lascito alla città di Padova da parte del Bottacin nel 1865 e al recente riallestimento della collezione, reso possibile dal crowdfunding lanciato dal museo Bottacin che ha dato un esito superiore alle aspettative. Paolo Renier ora ci attende sorridente e all'oscuro del tiro giocatogli dall'amico in un'accogliente saletta del secondo piano di Palazzo Zuckermann a Padova.