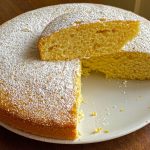IL PERSONAGGIO
«Quando ho saputo che il capitano della Fiorentina Astori era morto nel sonno mi sono sentito nello stomaco come una cosa strana. Facevo il tifo per lui anche perchè aveva il 13 sulla maglia e io sono legato al 13: ho vinto il tredicesimo scudetto della Juventus, mio fratello Fiorenzo, mio figlio e mio nipote sono nati il 13».
Non è il primo morto nel calcio
«Ho visto morire un amico, nel 1969, Giuliano Taccola centravanti della Roma. E' morto a Cagliari negli spogliatoi, gli facevano iniezioni per affrettarne il recupero dopo un infortunio. Con i compagni della Juve siamo andati a salutarlo, era bianco come il marmo. Sono morti troppi giovani nel calcio per non avere qualche sospetto».
In vent'anni di professionismo mai avuto un aiutino?
«Quando ho incominciato ero ancora un ragazzino, un medico prima della partita faceva a tutti un'iniezione dicendo che ci rendeva più resistenti alla fatica. Alla quarta volta ho detto: Sono giovane, non ne ho bisogno. La mia droga era una cotoletta con un uovo sopra e un bicchiere di vino rosso. Forse sono stato fortunato, leggendo quello che ha scritto Carlo Petrini, col quale ho giocato nel Genoa e nel Verona, sono rimasto allibito: non sapevo che circolasse tutta questa roba nel calcio».
Gianfranco Zigoni, 73 anni, nato a Oderzo, uno scudetto con la Juve, vent'anni in serie A, 265 partite e 63 gol con le maglie di Juventus, Genoa, Roma e Verona. Un libro sulla sua storia, Dio Zigo pensaci tu, scritto con l'amico Ezio Vendrame. Otto fratelli, uno era nazionale di atletica, ha corso con Arese; un altro era pugile dilettante, categoria superwelter, emigrò in Svizzera dopo che il padre sentenziò I pugni non ti danno bistecche da mangiare.
Come è iniziata la carriera di Zigoni calciatore?
«E' tutto incominciato qui, dove siamo adesso, il quartiere Marconi creato dal fascismo, il nostro Bronx. C'erano sessanta famiglie e trecento abitanti, adesso ci saranno cinquanta persone. Erano tutti campi incolti per giocare e si andava a pescare nel fiume che girava attorno e ora non c'è più. Ci accontentavamo di poco: ma davvero quello era poco? Ognuno di noi aveva un soprannome che conserviamo: mio fratello Fiorenzo era Tatino, uno Limon, un altro Butoea, il lombrico, e Ortighe perché pungeva, e Tarzan e Kociss. Io ero Duce, ma solo perché ero un piccolo boss, non per le mie idee: sono sempre stato per il Che».
Quando il Duce è diventato Dio Zigo?
«Giocavo a basket, ho ancora il tesserino, e a Treviso sono diventato campione veneto di tennis da tavolo. Mi piaceva soprattutto il rugby, ancora oggi faccio il tifo per i Grifoni di Oderzo. Per il calcio c'era l'oratorio, un osservatore della Juventus ha chiesto al parroco di mandarmi a Pordenone per fare un provino, mi ha convinto mia madre. Il grande Viri Rosetta, che era stato campione del mondo, dopo mezz'ora mi fece uscire: Ragazzino basta così, ti abbiamo preso. L'anno dopo ero a Torino, mi ha accompagnato mio padre in treno».
Come si stava alla Juve?
«Ho esordito a 17 anni a Udine, allenatore il grande Carletto Parola quello della rovesciata delle figurine Panini. Era una leggenda, ma aveva conservato la modestia. La linea d'attacco era: Mora-Rosa-Nicolè-Zigoni-Rossano. Segnò Nicolè su una mia azione, ma abbiamo perso. E ho perso anche il premio partita di 80 mila lire, un tesoro per me che ne guadagnavo 15 mila al mese. Mora in pullman rideva: Ho visto un bel cappotto di cachemire in vetrina a Udine, peccato, potevi comprarlo!. Essere la riserva di Sivori voleva dire giocare poco, ma Omar Sivori è stato il più grande di tutti: 60 anni fa faceva cose che pochissimi fanno adesso. Ricordo la mia partita con gol alla gloriosa Spal alla quale voglio bene e dove mio figlio Gianmarco era quasi un mito (ora gioca nel Venezia ndr). Mio figlio è più serio e più forte di me».
La partita più bella con la Juventus?
«Quella a cui tengo di più è l'ultima, contro la Lazio, quando ho fatto il gol che è valso il tredicesimo scudetto bianconero. Però il gol da ricordare è quello al Real Madrid di Di Stefano e Puskas, anche se abbiamo perso 3-1. Con la Juve ho vinto uno scudetto, ho avuto il trofeo De Martino come miglior giovane calciatore italiano, ho indossato la maglia della Nazionale, sono tra quelli che hanno portato l'Italia al titolo Europeo del 1968».
Gli anni della Roma
«Meravigliosi, avevamo una grande squadra: Vieri padre, Amarildo, Del Sol, io, Cordova, Cappellini. Ero in albergo con Del Sol, arrivano decine di tifosi e ci portano nei Colli, a Frascati, tutta la notte a mangiare e bere. Ho pensato: Questo è il mio ambiente, mio Dio sono caduto bene!. L'allenatore Helenio Herrera era innamorato della giornalista Flora Gandolfi, a una certa ora scappava e noi un minuto dopo eravamo tutti in giro. Così bene mi sono trovato solo a Verona, anche qui la prima notte sono arrivati i tifosi che ci hanno portato nella Valpolicella a bere».
Quel giorno che il Milan perse lo scudetto a Verona
«Il Milan di Rocco non poteva perdere. Il presidente Garonzi scese negli spogliatoi e promise un premio doppio. Ci ha indispettito lo stadio, le bandiere gialloblu erano state fatte sparire. I rossoneri non erano stanchi, il grande Pizzaballa non si trovava sulle figurine ma in porta c'era sempre, ha fatto due miracoli su Rivera; poi con un'azione personale ho messo la palla giusta sulla testa di Sirena e a seguire Luppi segnò due volte. Il Milan andò in confusione, si fece anche due autogol e il titolo fu della Juve per un punto».
E quella storia della pelliccia sopra la maglietta in panchina?
«Io la mettevo sempre la pelliccia d'inverno e portavo sotto la pistola, una Smith-Wesson. Lasciavo tutto negli spogliatoi. Avevano vinto la domenica prima senza di me e Valcareggi mi disse: Zigo, oggi non giochi. Io lo guardai: Come, io non gioco? Il più grande giocatore del mondo. Dovevo andare in panchina e decisi di farlo con la mia pelliccia di lupo e col mio cappello da cow-boy. Mi sembrava una cosa normale, lo giuro non credevo di fare scalpore; furono i compagni a farmi capire che era una cosa strana».
Pensa di aver sprecato il talento?
«Certo, ho reso il 30% e non è una frase fatta. Quando ho smesso avevo 35 anni. A chi assomigliavo? A George Best, però lui si allenava molto, beveva di più e superalcolici. Io vino Raboso, quello che fa la leggenda del mio amico Mauro Corona».
Edoardo Pittalis
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA «Quando ho saputo che il capitano della Fiorentina Astori era morto nel sonno mi sono sentito nello stomaco come una cosa strana. Facevo il tifo per lui anche perchè aveva il 13 sulla maglia e io sono legato al 13: ho vinto il tredicesimo scudetto della Juventus, mio fratello Fiorenzo, mio figlio e mio nipote sono nati il 13».
Non è il primo morto nel calcio
«Ho visto morire un amico, nel 1969, Giuliano Taccola centravanti della Roma. E' morto a Cagliari negli spogliatoi, gli facevano iniezioni per affrettarne il recupero dopo un infortunio. Con i compagni della Juve siamo andati a salutarlo, era bianco come il marmo. Sono morti troppi giovani nel calcio per non avere qualche sospetto».
In vent'anni di professionismo mai avuto un aiutino?
«Quando ho incominciato ero ancora un ragazzino, un medico prima della partita faceva a tutti un'iniezione dicendo che ci rendeva più resistenti alla fatica. Alla quarta volta ho detto: Sono giovane, non ne ho bisogno. La mia droga era una cotoletta con un uovo sopra e un bicchiere di vino rosso. Forse sono stato fortunato, leggendo quello che ha scritto Carlo Petrini, col quale ho giocato nel Genoa e nel Verona, sono rimasto allibito: non sapevo che circolasse tutta questa roba nel calcio».
Gianfranco Zigoni, 73 anni, nato a Oderzo, uno scudetto con la Juve, vent'anni in serie A, 265 partite e 63 gol con le maglie di Juventus, Genoa, Roma e Verona. Un libro sulla sua storia, Dio Zigo pensaci tu, scritto con l'amico Ezio Vendrame. Otto fratelli, uno era nazionale di atletica, ha corso con Arese; un altro era pugile dilettante, categoria superwelter, emigrò in Svizzera dopo che il padre sentenziò I pugni non ti danno bistecche da mangiare.
Come è iniziata la carriera di Zigoni calciatore?
«E' tutto incominciato qui, dove siamo adesso, il quartiere Marconi creato dal fascismo, il nostro Bronx. C'erano sessanta famiglie e trecento abitanti, adesso ci saranno cinquanta persone. Erano tutti campi incolti per giocare e si andava a pescare nel fiume che girava attorno e ora non c'è più. Ci accontentavamo di poco: ma davvero quello era poco? Ognuno di noi aveva un soprannome che conserviamo: mio fratello Fiorenzo era Tatino, uno Limon, un altro Butoea, il lombrico, e Ortighe perché pungeva, e Tarzan e Kociss. Io ero Duce, ma solo perché ero un piccolo boss, non per le mie idee: sono sempre stato per il Che».
Quando il Duce è diventato Dio Zigo?
«Giocavo a basket, ho ancora il tesserino, e a Treviso sono diventato campione veneto di tennis da tavolo. Mi piaceva soprattutto il rugby, ancora oggi faccio il tifo per i Grifoni di Oderzo. Per il calcio c'era l'oratorio, un osservatore della Juventus ha chiesto al parroco di mandarmi a Pordenone per fare un provino, mi ha convinto mia madre. Il grande Viri Rosetta, che era stato campione del mondo, dopo mezz'ora mi fece uscire: Ragazzino basta così, ti abbiamo preso. L'anno dopo ero a Torino, mi ha accompagnato mio padre in treno».
Come si stava alla Juve?
«Ho esordito a 17 anni a Udine, allenatore il grande Carletto Parola quello della rovesciata delle figurine Panini. Era una leggenda, ma aveva conservato la modestia. La linea d'attacco era: Mora-Rosa-Nicolè-Zigoni-Rossano. Segnò Nicolè su una mia azione, ma abbiamo perso. E ho perso anche il premio partita di 80 mila lire, un tesoro per me che ne guadagnavo 15 mila al mese. Mora in pullman rideva: Ho visto un bel cappotto di cachemire in vetrina a Udine, peccato, potevi comprarlo!. Essere la riserva di Sivori voleva dire giocare poco, ma Omar Sivori è stato il più grande di tutti: 60 anni fa faceva cose che pochissimi fanno adesso. Ricordo la mia partita con gol alla gloriosa Spal alla quale voglio bene e dove mio figlio Gianmarco era quasi un mito (ora gioca nel Venezia ndr). Mio figlio è più serio e più forte di me».
La partita più bella con la Juventus?
«Quella a cui tengo di più è l'ultima, contro la Lazio, quando ho fatto il gol che è valso il tredicesimo scudetto bianconero. Però il gol da ricordare è quello al Real Madrid di Di Stefano e Puskas, anche se abbiamo perso 3-1. Con la Juve ho vinto uno scudetto, ho avuto il trofeo De Martino come miglior giovane calciatore italiano, ho indossato la maglia della Nazionale, sono tra quelli che hanno portato l'Italia al titolo Europeo del 1968».
Gli anni della Roma
«Meravigliosi, avevamo una grande squadra: Vieri padre, Amarildo, Del Sol, io, Cordova, Cappellini. Ero in albergo con Del Sol, arrivano decine di tifosi e ci portano nei Colli, a Frascati, tutta la notte a mangiare e bere. Ho pensato: Questo è il mio ambiente, mio Dio sono caduto bene!. L'allenatore Helenio Herrera era innamorato della giornalista Flora Gandolfi, a una certa ora scappava e noi un minuto dopo eravamo tutti in giro. Così bene mi sono trovato solo a Verona, anche qui la prima notte sono arrivati i tifosi che ci hanno portato nella Valpolicella a bere».
Quel giorno che il Milan perse lo scudetto a Verona
«Il Milan di Rocco non poteva perdere. Il presidente Garonzi scese negli spogliatoi e promise un premio doppio. Ci ha indispettito lo stadio, le bandiere gialloblu erano state fatte sparire. I rossoneri non erano stanchi, il grande Pizzaballa non si trovava sulle figurine ma in porta c'era sempre, ha fatto due miracoli su Rivera; poi con un'azione personale ho messo la palla giusta sulla testa di Sirena e a seguire Luppi segnò due volte. Il Milan andò in confusione, si fece anche due autogol e il titolo fu della Juve per un punto».
E quella storia della pelliccia sopra la maglietta in panchina?
«Io la mettevo sempre la pelliccia d'inverno e portavo sotto la pistola, una Smith-Wesson. Lasciavo tutto negli spogliatoi. Avevano vinto la domenica prima senza di me e Valcareggi mi disse: Zigo, oggi non giochi. Io lo guardai: Come, io non gioco? Il più grande giocatore del mondo. Dovevo andare in panchina e decisi di farlo con la mia pelliccia di lupo e col mio cappello da cow-boy. Mi sembrava una cosa normale, lo giuro non credevo di fare scalpore; furono i compagni a farmi capire che era una cosa strana».
Pensa di aver sprecato il talento?
«Certo, ho reso il 30% e non è una frase fatta. Quando ho smesso avevo 35 anni. A chi assomigliavo? A George Best, però lui si allenava molto, beveva di più e superalcolici. Io vino Raboso, quello che fa la leggenda del mio amico Mauro Corona».
Edoardo Pittalis
© RIPRODUZIONE RISERVATA